Un vita come tante e un romanzo che tradisce
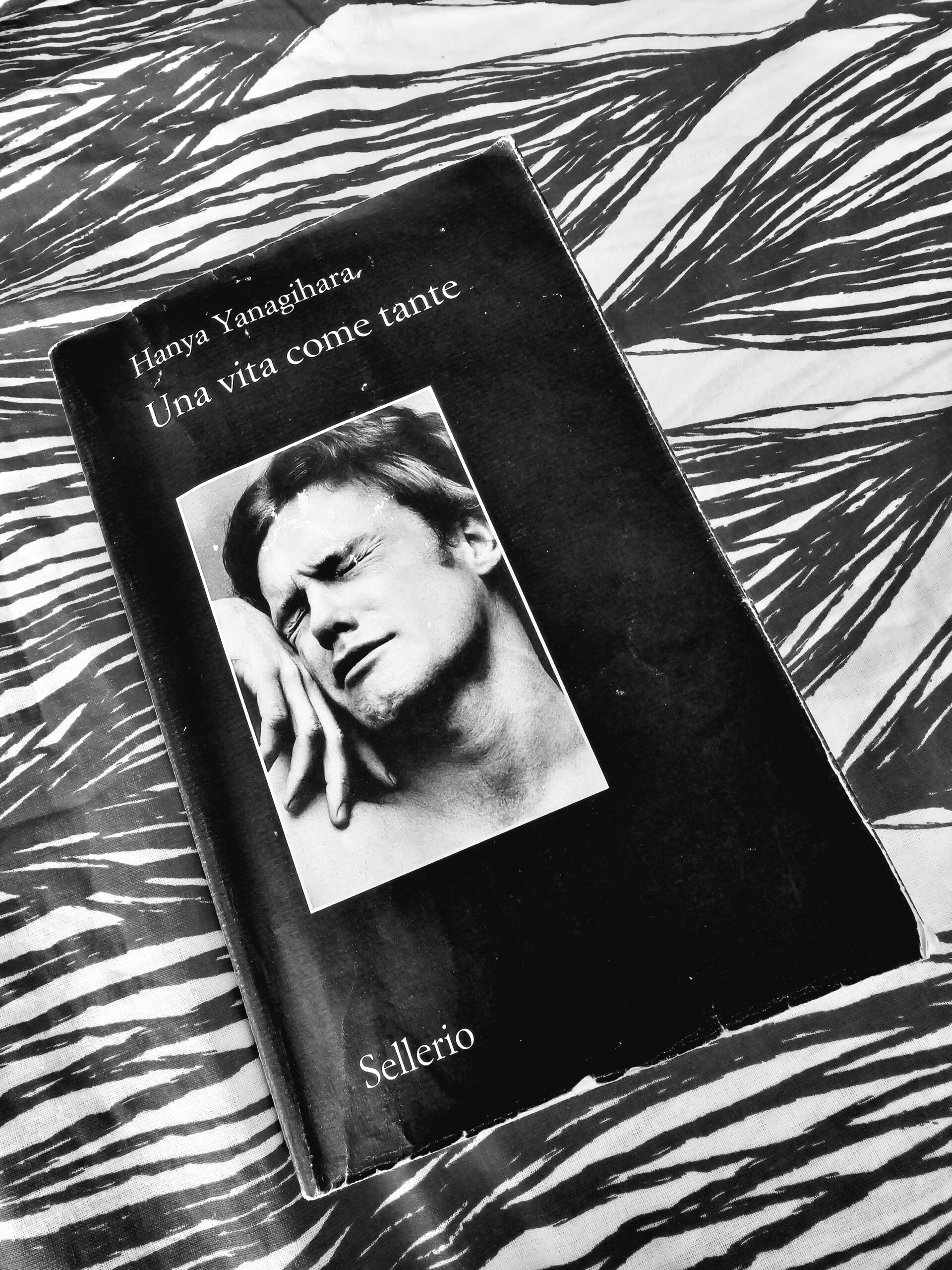
Ci sono libri che ti trovano… e avresti preferito che non lo facessero. “Una vita come tante” è un romanzo che ti illude, con una prosa – e una traduzione – in alcune parti bellissima, una forza narrativa clamorosa e atmosfere che ricordano la New York di David Leavitt. È un romanzo che tradisce il lettore, che ingenuamente non si lascia mettere in guardia dal nome del protagonista: Jude.
Un romanzo che ti prende a schiaffi, e ti disgusta spesso, con una storia cupa e violenta, che fa venir voglia di chiedere pietà all’autore.
Basta! Verrebbe da dire: non è necessario accanirsi, gettando tutti i mali del mondo e della nostra società, su un unico, sfortunato, personaggio e sui pochi per i quali prova affetto. E il paradosso, però, è che mentre si fatica a deglutire, leggendo le terribili vicissitudini che Jude ha sopportato, non si riesce, nemmeno un momento, a provare empatia nei suoi confronti.
Un moderno orfano dickensiano, che porta i segni di un passato inimmaginabile, che non suscita pietà. E anche non riuscire a provare empatia verso chi, innegabilmente, viene sferzato dai colpi del destino, finisce per far provare un senso di disagio.
Manca la speranza in questo libro, manca il sovvertimento degli stereotipi: i buoni sono generosi, comprensivi, pazienti; i cattivi sono i più cattivi del mondo, esempi tipici di quella banalità del male che si nasconde dietro maschere rispettabili, ma alimenta, alla fine, i mostri. E questa carenza di colpi di scena, questa finta profondità dei personaggi, che di fatto sono caricature, è talmente fastidiosa da spingerti a leggere in cerca di una segno di svolta.
Se di “Una vita come tante” esistesse la versione cinematografica, non potrei guardarla. Perché quello che salva dall’orrore raccontato in alcune pagine, è la possibilità di immaginare un po’ di meno, non concentrarsi sui particolari, leggere senza partecipare alle azioni. Rimane da chiedersi che bisogno c’è di trascinare il lettore per oltre mille pagine, nell’attesa che la luce, da qualche parte, spunti e non venga brutalmente e puntualmente spenta. Forse un esercizio di stile? O un procedimento catartico, che consiste nel mettere in parola le proprie più profonde paure? Ad ogni modo, di questo lunghissimo, manipolatore, romanzo mi rimarrà – oltre al fastidio – un briciolo di simpatia per il peggiore dei quattro personaggi principali: Jb. il più umano, il più concreto, l’unico che non custodisce in sé sentimenti archetipici – il bene assoluto, il dolore più profondo, la generosità più disinteressata -, ma quelli più banali e confortanti degli essere umani: amore, che viene e va, gelosia insicurezza, ambizione, frustrazione, talento. Qualità che, molto umanamente e sfuggendo, forse, alle attenzioni dell’autore, sta al personaggio tentare di mettere a frutto: un po’ come capita a noi che viviamo, davvero, vite come tante.
Clelia Pettini